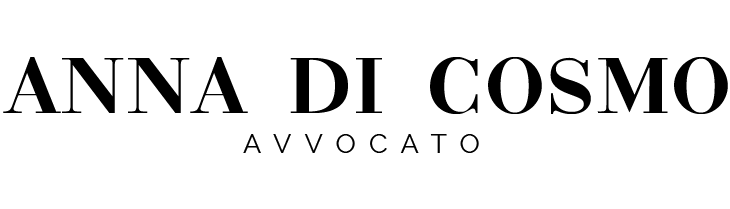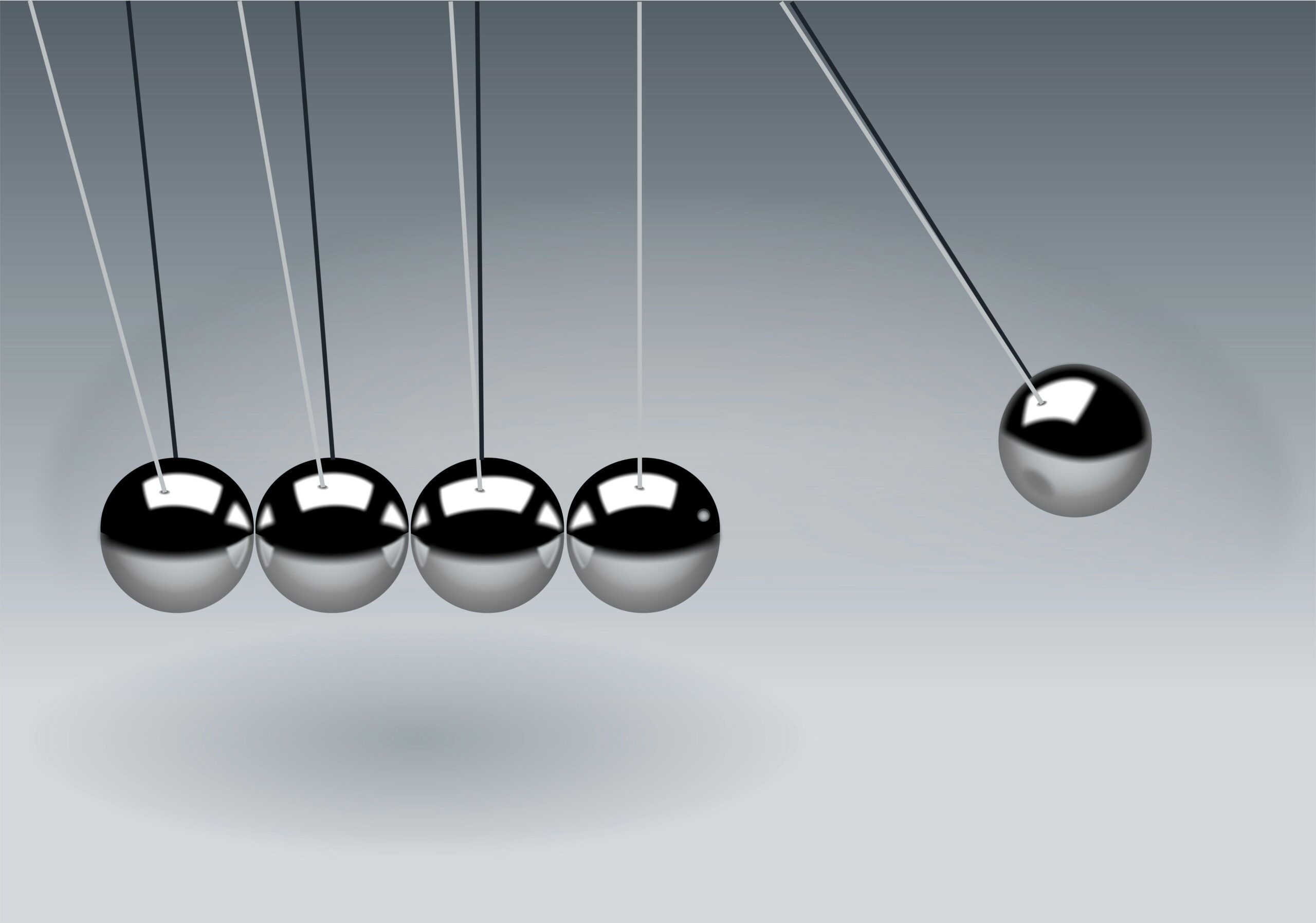In caso di disaccordo genitori/personale medico, esiste una procedimentalizzazione per la formazione e manifestazione del consenso alla scelta dei trattamenti sanitari sui minori.
Con la sent. n. 2549 del 03/02/2025 la Cassazione civile sez. I è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un provvedimento del Giudice Tutelare che aveva accordato al Direttore generale di un Ospedale il potere di esprimere il consenso ad un intervento chirurgico su un minore, con elevata probabilità di trasfusioni ematiche.
I genitori avevano espresso un consenso condizionato (la condizione era che il sangue provenisse da donatori non vaccinati contro il Covid-19) adducendo motivazioni di salute e di etica religiosa.
L’azienda ospedaliera, non potendo garantire tale condizione, aveva fatto ricorso al Giudice Tutelare, il quale aveva adottato la suddetta autorizzazione, motivandola.
La Legge n. 219/2017, comunemente nota come Legge sulle Direttive Anticipate di Trattamento (Legge DAT), prevede che “il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità” (art. 3, 2°comma).
Il diritto di scegliere i trattamenti sanitari – previa adeguata informazione – è strettamente collegato non solo alla tutela della salute e della vita, ma anche alla libertà di autodeterminarsi e quindi, in definitiva, al rispetto della dignità della persona umana, espressione di un diritto costituzionalmente garantito: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana” (art. 32, 2° comma Cost.).
La titolarità di tali diritti è assicurata alla persona fin dal momento della sua nascita, ma l’esercizio degli stessi compete ai genitori del minore, che ne sono i legali rappresentanti.
L’esercizio della responsabilità genitoriale, tuttavia, non è arbitrario, bensì è connotato da diritti e doveri ed è governato dalla regola dell’accordo tra i genitori finalizzato alla realizzazione del best interest del minore (Corte Cost. n. 71/2024). Finalità che legittima, nei casi di trascuratezza, violazione di doveri o abuso della funzioni, un’ingerenza dello Stato, che altrimenti sarebbe indebita.
I genitori devono infatti: a) tenere conto della volontà del minore, tramite il suo ascolto, “in relazione alla sua età e al suo grado di maturità” e cioè anche a prescindere dal fatto che abbia compiuto gli anni 12 ; b) avere come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità e quindi dare spazio anche al parere dei medici, e in genere della comunità scientifica poiché questo consente di ancorare la scelta ad un dato oggettivo e di perseguire effettivamente lo scopo.
Prima della Legge DAT, in caso di ingiustificato rifiuto genitoriale a cure mediche utili o necessarie per i minori, si poneva rimedio con una temporanea limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale, che poteva risultare spropositata.
Per effetto della Legge DAT invece “Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l’amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all’articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria” (art. 3, 5°comma).
Pertanto, in ipotesi di disaccordo con il personale medico, per effetto della Legge DAT, il Giudice non è più chiamato ad agire sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale (salvo che il rifiuto alle cure non si inquadri in una situazione di più generale trascuratezza), ma si limita ad applicare un meccanismo che opera solo in relazione ad un determinato compito genitoriale, non adeguatamente assolto.
La norma consente al Giudice tutelare, adito dai medici o dagli altri soggetti indicati dalla norma, di decidere se un certo intervento/trattamento possa aver luogo anche senza il consenso dei genitori, così comprimendo il diritto di costoro di autodeterminarsi (di comune accordo) nelle scelte da fare nella cura dei figli minori e direttamente provvedendo in merito, in un settore ove le scelte comportano effetti nella vita del minore, potenzialmente irreversibili.
La ingiustificata compressione della sfera di autodeterminazione dei genitori, ed eventualmente anche di quella del minore – nei limiti in cui si può tenere conto della sua opinione, è un fatto storico che si produce in ogni caso, quale effetto del provvedimento giudiziale, e ha una sua rilevanza a prescindere dalla buona o cattiva riuscita dell’intervento autorizzato (Cass. n. 24471/2020; Cass. n. 16633/2023).
La Cassazione quindi, confermando un orientamento già espresso in precedenza, inquadra preliminarmente tali provvedimenti tra quelli aventi natura decisoria su diritti soggettivi personalissimi.
Passando alla valutazione circa la conformità a norme di diritto delle ragioni espresse dal Giudice Tutelare, la Suprema Corte sancisce che il consenso ad un trattamento sanitario sottoposto ad una condizione non attuabile equivale ad un consenso non espresso (anche se, nella fattispecie, la condizione non era attuabile – non in linea generale- ma solo presso la struttura sanitaria da loro scelta).
Quanto alle motivazioni religiose addotte dai genitori e disattese dal Giudice Tutelare, la Cassazione osserva come si sia trattato di “scelta di coscienza religiosa, sulla base della interpretazione individuale di un testo di dottrina”, in quanto la posizione espressa dalla Chiesa Cattolica non è apertamente contraria alla somministrazione del vaccino anti Covid 19.
Inoltre, osserva la Corte, i genitori incorrono in errore di diritto laddove sovrappongono la loro identità religiosa a quella del figlio minore ( “se pure è compito e prerogativa dei genitori dare al figlio una educazione anche sotto il profilo religioso, non può non considerarsi che le scelte religiose future del minore potrebbero essere diverse e pertanto non è accettabile che i genitori adottino decisioni per il minore in cui la loro fede religiosa sia assolutamente condizionante e prevalga in ogni caso sempre e comunque sugli altri interessi del minore. Ciò è stato ripetutamente affermato da questa Corte, la quale ha rimarcato che in tema di scelte religiose resta comunque preminente la considerazione del miglior interesse del minore, e del suo diritto ad una crescita sana ed equilibrata (Cass. n. 21916/2019; Cass. n. 12954/2018). Non incorre quindi in errore di diritto il giudice che bilanci le scelte religiose dei genitori con altri diritti ed interessi del minore, quali il diritto alla salute psico-fisica e ad una armoniosa crescita e decida, in questa operazione di bilanciamento, quale scelta attui il miglior interesse del minore; “).
Ma i genitori adducevano una ulteriore motivazione, ossia che il Giudice Tutelare non avesse adeguatamente valutato il rischio connesso al circolo della proteina spike nel sangue di un minore già gravato da patologia cardiovascolare.
Su questo argomento la Cassazione dichiara di non potersi pronunciare perché trattasi di valutazione di merito che non compete al Giudice di legittimità : “ La scelta tra più teorie scientifiche è un aspetto del libero convincimento del giudice del merito (Cass. n. 43786/2010) al quale è rimesso il prudente apprezzamento delle prove (Cass. n. 28453/2024) e di cui si deve dare conto in motivazione”.
Su tale argomento il Giudice Tutelare aveva ritenuto la richiesta di sangue proveniente da donatori non vaccinati come “irragionevole”, ritenendo attendibile l’opinione espressa dalla comunità scientifica secondo la quale non vi sarebbe differenza alcuna tra sangue di soggetti vaccinati e non.
Così operando, secondo la Cassazione, il Giudice non ha commesso alcun errore di diritto e nel motivare tale assunto la Cassazione enuncia un altro importante principio, di grande attualità:
“Quando il giudice deve fondare la propria scelta su una opinione scientifica tiene conto indubbiamente del fatto che gli studi scientifici hanno sempre un margine di fallibilità e possono essere nel futuro smentiti, e che nessun trattamento medico è assolutamente sicuro, comportando sempre un margine di rischio più o meno rilevante. Il giudizio è stato tuttavia espresso allo stato degli atti e delle conoscenze disponibili e nel momento in cui doveva eseguirsi l’intervento“.